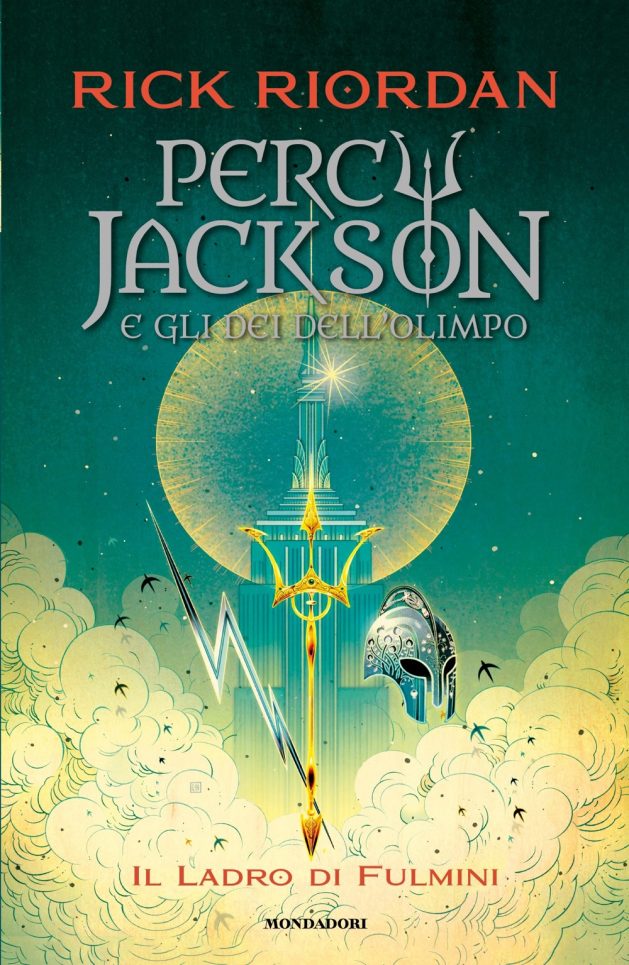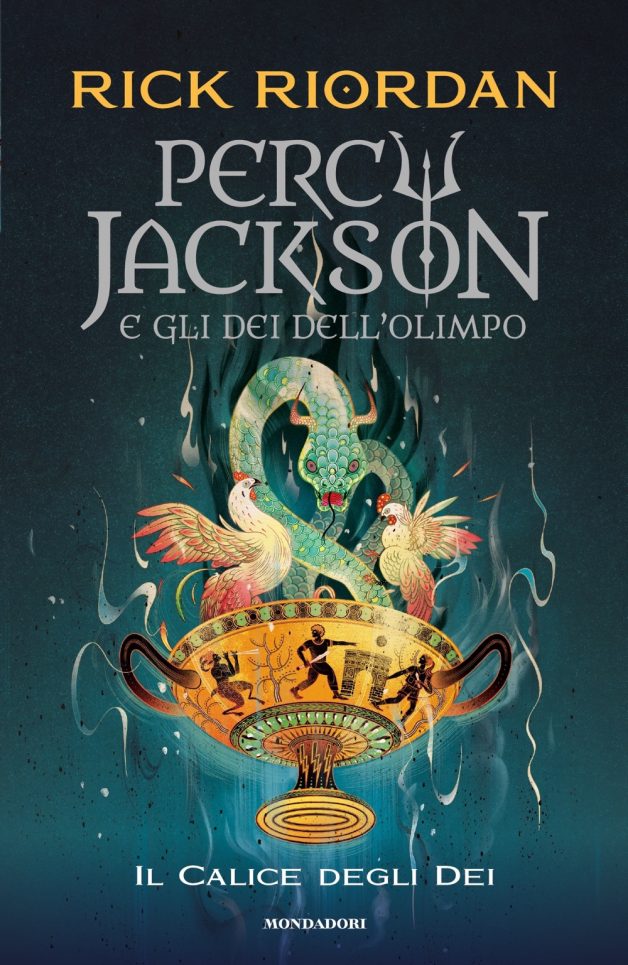Marco Magnone è tornato in libreria questa primavera con Fino alla fine del fiato, un emozionante romanzo rivolto (non solo) agli adolescenti.
Avevamo scoperto come fosse nata l’opera grazie alla testimonianza dell’autore, ma non è finita qui!
Viviana Mazza lo ha intervistato in esclusiva per noi!
Questo libro è ispirato dalla strage nell’isola di Utoya, in Norvegia, dove un fanatico di estrema destra uccise sessantanove persone, soprattutto adolescenti. Perché anziché raccontare quella vicenda hai preferito immaginarne una simile ambientata in Italia?
Nel 2019 ho avuto la fortuna di incontrare alcuni sopravvissuti della strage compiuta dal terrorista Anders Breivik il 22 luglio 2011 – esattamente dieci anni fa – nel corso di un campo estivo, che come ogni estate si teneva sull’isola di Utoya, poco a nord di Oslo. Ragazzi e ragazze che all’epoca dell’attentato avevano quattordici o quindici anni, e che hanno condiviso con me il racconto di come sono riusciti a sopravvivere quel giorno, e di come in seguito sono tornati a vivere. A ritrovare il coraggio – dopo aver perso amici, sorelle, fidanzati – di aprire di nuovo la porta di casa, di tornare a uscire con gli amici, di innamorarsi ancora. Liberandosi da una paura che rischiava di segnali per sempre, diventando una prigione senza vie d’uscita. Le loro parole hanno iniziato a lavorare dentro di me, fino a farmi capire che quanto successo quel giorno e nei mesi seguenti era qualcosa che andava oltre alla cronaca del tempo e alle vicende politiche norvegesi. Era qualcosa di universale, un archetipo che metteva a confronto due opposti. Da una parte c’erano gli adolescenti che prendevano parte al campo, con la loro fame di vita che si manifestava nelle forme più varie, dall’organizzazione delle attività in cui impegnarsi alla voglia di socialità, tra nuove amicizie e primi amori. Dall’altra invece c’era un uomo in cui la fame di vita si era spenta, lasciandolo senza passioni e con l’unico argomento della violenza. Ecco, provare raccontare l’incontro tra i sogni dell’adolescenza e il loro esatto contrario era il mio intento. Sia nel momento della caduta, quello in cui quei sogni diventano incubi, sia in quello del riscatto, quando chi è sopravvissuto deve fare i conti col il ritorno alla vita. Per questo ho preso spunto dalla vicenda di Utoya e Breivik per andare oltre, dando vita a un’ambientazione che i miei lettori e le mie lettrici potessero sentire il più possibile vicina a loro: un campo estivo in montagna, come tanti organizzato da associazioni giovanili e studentesche per confrontarsi su cause come la lotta per l’ambiente e i diritti, o contro l’illegalità le diseguaglianze. Così sono nati anche i tre protagonisti di Fino alla fine del fiato, Seba, Filo e Marti. E a oggi credo proprio che, per il carico emotivo che mi portavo dietro, nessun altro personaggio mi abbia messo maggiormente alla prova di loro, come autore, e non solo.
Uno dei temi centrali è la difficoltà dei maschi ad esprimersi con le parole. Cosa significa essere ragazzo e poi uomo nella società di oggi? Sono tematiche sulle quali come scrittore, organizzatore di progetti di educazione alla lettura, ma anche come uomo e adesso anche come padre hai riflettuto molto?
È evidente come purtroppo la questione maschile sia ancora molto lontano dall’essere risolta. Troppi maschi infatti continuano a credere di poter tenere certi comportamenti, di poter utilizzare certe parole, di poter condividere certe idee nei confronti delle donne, per il semplice fatto che così è avvenuto in passato. Ma questo non è più possibile né giustificabile, e proprio noi uomini dovremmo essere in prima linea per opporci, e per contribuire a scrivere un’altra storia: una storia in cui tutti insieme proviamo a dare forma a un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti. Per farlo dovremmo innanzitutto liberarci dagli stereotipi che ancora abitano, in modo più o meno consapevole, le teste di troppe persone. Come? Attraverso le parole. Le parole sono la base di tutto. Delle nostre opinioni, dei nostri comportamenti. Se io dico una cosa, e magari continuo a ripeterla ai miei amici, e la scrivo sui social, chi mi ascolta può pensare che quella determinata cosa sia normale, sia accettabile, al punto da iniziare a fare a sua volta lo stesso. Il problema è che troppe volte le parole che noi usiamo non sono affatto normali né accettabili. Sono parole che offendono altre persone, le discriminano, le isolano, fanno loro male. Parole violente che creano la base perché qualcuno, prima o poi, pensi che sia altrettanto normale passare dalla violenza verbale ad altre forme, ancora più gravi. È quello che ha fatto proprio Anders Breivik dopo anni in cui ha condiviso parole, idee e opinioni xenofobe, misogine, razziste e ultra-nazionaliste. Per impedire che orrori del genere possano ripetersi non ci resta che impegnarci, ognuno di noi, indipendentemente dall’età che abbiamo e la posizione che occupiamo, per cambiare il modo in cui utilizziamo le parole. Solo così potremo cambiare anche il mondo. Un pezzetto alla volta, un giorno dopo l’altro. Come scrittore, compagno e padre non posso far altro che partire da qui: pensare che se qualcosa è stato fatto in un certo modo fino a oggi, questo non significa affatto che sia giusto, e che non si possa – anzi si debba – fare meglio, d’ora in poi, per le vite che verranno.
La gravità dei cambiamenti climatici e l’importanza di pensare all’ambiente per il nostro futuro è uno dei temi più sentiti dalla generazione di cui parli nel tuo romanzo. Ma accanto a questo c’è il tema della dignità del lavoro, della disoccupazione e dalle difficoltà generate dai cambiamenti dell’economia e delle differenze di classe sociale. Anche queste sono riflessioni che emergono da questo tuo libro. Ne avevamo discusso in un incontro a Mare di Libri in cui tu eri il moderatore e io la speaker con il mio libro su Greta Thunberg. Adesso mi piacerebbe conoscere le tue idee su questo tema!
Io credo fortemente che i diritti delle persone non possano in nessun caso esser messi in contrapposizione l’uno con l’altro. A questo proposito pensare che si debba scegliere tra la lotta per l’ambiente e quella il lavoro è una grossa bugia, per un motivo molto semplice: ognuno di noi ha il diritto di ambire a una vita dignitosa, e una vita dignitosa significa un equilibrio tra diverse cose. Per esempio il diritto alla salute, nostra e di chi verrà dopo di noi, che non possono essere garantite senza un cambiamento dei sistemi produttivi e delle abitudini individuali nell’ambito di una maggiore sostenibilità ambientale. Ma anche il diritto a una maggior inclusione sociale, che non può esistere se non saremo in grado di ridurre le inaccettabili diseguaglianze tra chi ha molto, e chi troppo poco. Ecco, io credo che chi sostiene si debba scegliere tra diritti, come per esempio tra ambiente e lavoro, lo faccia sotto sotto per dividere le persone che si impegnano per un reale cambiamento, così da mantenere lo status quo, e magari continuare a godere dei propri piccoli o grandi privilegi che altrimenti teme di perdere. I diritti non sono una risorsa limitata, che da contenderci l’uno con l’altro come in una guerra tra poveri prima che finiscano. Al contrario sono un bene comune, che dovremmo difendere insieme, nel loro complesso. Perché ogni volta che viene negato un diritto a qualcuno, a perderci non sono solo i diretti interessati ma tutti, anche chi pensa di non essere coinvolto. E invece lo è eccome, dal momento che altrimenti quel qualcuno a cui potrebbe venir tolto il prossimo diritto, prima o poi, potremmo essere proprio noi.
Fino alla fine del fiato di Marco Magnone è in libreria.